Non sempre il potere è coercizione, ma spesso nessuno ci crede
Thomas Hobbes definiva il potere come le facoltà dei sovrani delegati dal popolo, mentre Rosseau lo pensava come una sorta di volontà generale. De Maistre alzava l’asticella attribuendo al potere una forma di volere divino, contrariamente a Karl Marx che esprimeva un concetto più terreno relegandolo all’attività esercitata da parlamentari e funzionari della borghesia. Un accostamento, quello di Marx, moderno e calzante capace di spiegare il fascino e la brama che il potere esercita in chiunque veda uno spiraglio per ottenerlo.
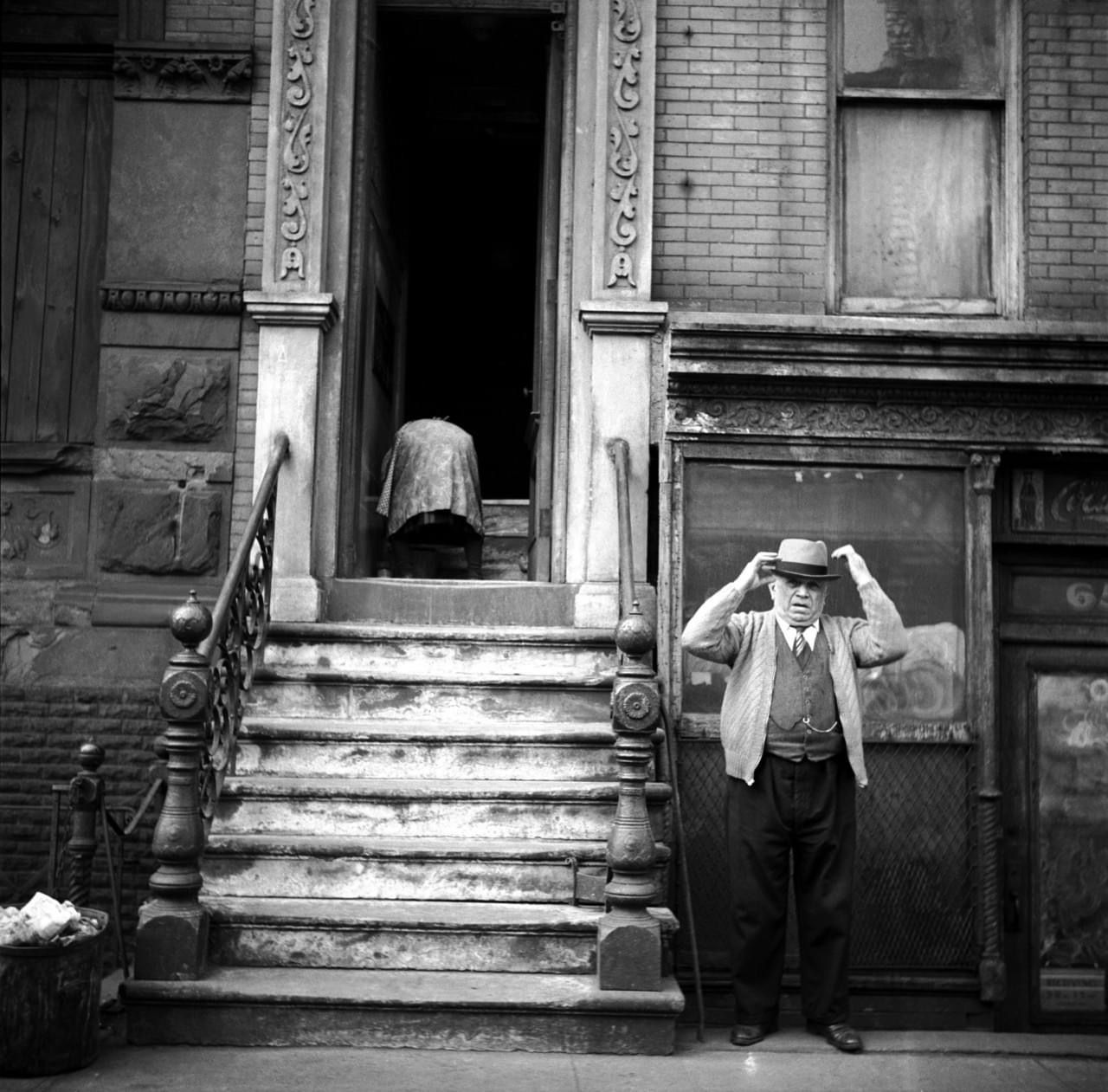
Oggi sparpagliati per il Brasile vivono circa cinquantunomila Guaranì, una popolazione che si avvicina per numero agli abitanti di una città come Siena o Mantova, ma di queste e di altre città poco o nulla condividono con particolare riferimento al concetto di amministrazione e potere.
Il potere, ossia l’autorità che si esercita sull’altro, per gli indigeni d’America è concepito secondo criteri molto diversi da quelli pensati dalle nostre comunità e Pierre Clastres –antropologo Parigino scomparso nel 1977– nel suo libro più famoso “La società contro lo Stato” tradotto e pubblicato di recente anche in Italia, lo ha chiarito senza mezze misure.
I Guaranì e la maggior parte delle popolazioni amerindi, ossia quelle che i colonizzatori hanno definito selvaggi, avevano un concetto di potere molto più evoluto del nostro in cui non esisteva alcuna forma di coercizione. L’idea d’imporre la volontà dell’uomo sull’uomo era totalmente sconosciuta così che i capi tribù, i capi villaggi e perfino i re delle grandi città rivestivano un ruolo di guida spirituale il cui compito era di tenere in equilibrio costante le esigenze di tutti. Certamente un lavoraccio dal momento che i diktat sono di gran lunga più comodi per chi è al vertice della piramide, ma spesso ingiusti e frustranti per chi è costretto a vivere alla base.
Secondo Clastres l’uomo al comando, il capo Amerindi, era sempre in debito con il suo popolo e non come accade nei nostri paesi dove il sottoposto è costretto a lavorare per garantire il mantenimento dei ruoli di potere spesso affidati a figure incoerenti e inconsistenti. Tra le antiche popolazioni d’America precolombiana non vi era alcuna forma d’imposizione fisica e morale, nessun privilegio derivante da conoscenze esclusive o da una forza economica capace di controllare ogni singolo individuo. Il potere non era esercitato con forme di terrore occulto o manifesto, una sgradevole sensazione che da sempre la maggior parte delle comunità ha dovuto sopportare, e sopporta tuttora. Le amministrazioni politiche spesso fanno leva su aspettative di benessere, sicurezza e salute della gente per ottenere l’autorizzazione al governo e al controllo; in poche parole, il potere, nel pensiero filosofico occidentale, è concepito come una forma di prevaricazione rispetto alla volontà di altri.

Thomas Hobbes definiva il potere come le facoltà dei sovrani delegati dal popolo, mentre Rosseau lo pensava come una sorta di volontà generale. De Maistre alzava l’asticella attribuendo al potere una forma di volere divino, contrariamente a Karl Marx che esprimeva un concetto più terreno relegandolo all’attività esercitata da parlamentari e funzionari della borghesia. Un accostamento, quello di Marx, moderno e calzante capace di spiegare il fascino e la brama che il potere esercita in chiunque veda uno spiraglio per ottenerlo.
Accostando il potere a quello di attività, ovvero alla pratica di organizzare e amministrare volontà e risorse per conseguire un profitto o un vantaggio, è abbastanza facile e naturale mirare al potere come a un’opportunità personale. Un vantaggio che i Guaranì avrebbero ripartito in egual misura nella loro comunità e, non come le civiltà occidentali che riversano il potere su pochi individui impegnati a circoscrivere la volontà e la libertà degli altri.
Sovente il potere è una forma d’oppressione camuffata da organizzazione della macchina statale; infatti, viene da ridere nel pensare a realtà come la Cina o la Russia che pur definendosi repubbliche amministrano la popolazione con un sistema dittatoriale. Forse, da questo punto di vista, la Cina potrebbe essere considerata meno ipocrita dal momento che la sua condizione di “dittatura democratica” è riportata nel primo articolo della sua Costituzione.
Dittatura che spesso si tende ad esercitare anche nei contesti domestici e sui luoghi di lavoro nei riguardi dei sottoposti o dei più deboli, con la scusa di farvi da guida, per una derivazione culturale a cui siamo stati abituati. L’idea di un’autorità di potere, che sia democraticamente eletta o che venga dal divino, è alla base della nostra antica educazione e organizzazione sociale, ma che spesso sfocia in malumori, proteste e rivolte senza porsi il minimo dubbio su come debba essere correttamente applicato il concetto di potere; azzardando, perfino, un’idea che si possa avvicinare al principio delle popolazioni precolombiane, affinché gli studi di Pierre Clastres non restino solo favole di speranza da raccontare ai bambini.
di Mario Volpe
Share
Tutti gli articoli












