La povertà educativa mangia il futuro dei nostri bambini - di Mario Sorrentino
Sono troppi i bambini che non hanno la possibilità di visitare una mostra, di andare al cinema, di leggere un libro, di fare sport: l’impoverimento culturale è in drammatico aumento, parallelamente al peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Un minore su 7 lascia prima la scuola, altri ragazzi non raggiungono le competenze di base alla fine del percorso di studi. Recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti ragazzi, gli stupri di Palermo e di Caivano ma non solo, fanno tornare a discutere di povertà educativa in un'Italia che si mostra anche in questo caso a due velocità tra Nord e Sud, centro e periferie, grandi città e aree interne. Come in un circolo vizioso, la povertà educativa alimenta quella economica, e viceversa.

di Mario Sorrentino ( già dirigente scolastico)
A mangiare il futuro dei ragazzi in Italia è la crescente povertà educativa nel Paese. Sono troppi i bambini che non hanno la possibilità di visitare una mostra, di andare al cinema, di leggere un libro, di fare sport: l’impoverimento culturale è in drammatico aumento, parallelamente al peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Un minore su 7 lascia prima la scuola, altri ragazzi non raggiungono le competenze di base alla fine del percorso di studi. Recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti ragazzi, gli stupri di Palermo e di Caivano ma non solo, fanno tornare a discutere di povertà educativa in un'Italia che si mostra anche in questo caso a due velocità tra Nord e Sud, centro e periferie, grandi città e aree interne. Come in un circolo vizioso, la povertà educativa alimenta quella economica, e viceversa.
Orbene, le nuove forme di marginalità e di povertà educative sono questioni tornate prepotentemente al vertice delle emergenze sociali, anche perché connesse a conseguenti fenomeni di devianza e di criminalità che coinvolgono, assai di frequente, ragazzi sempre più giovani. Poco più che bambini, spesso attraversati da un comune destino di incuria educativa e di abbandono morale, si ritrovano sempre più soli, per strada, dove trovano rifugio nel branco e dove più facilmente incappano in condotte devianti, che di frequente sfociano in gravi atti criminali. Tutti questi motivi costituiscono senz’altro humus di una predisposizione al rischio, che chiaramente non può e non deve rappresentare, tuttavia, una predestinazione certa. Bisogna chiedersi, cosa possa spingere un minore a delinquere, commettendo azioni, anche molto rischiose, a fronte di un profitto, a volte, anche modesto, come furti, scippi, rapine, fino allo spaccio della droga che è, inesorabilmente, controllato da organizzazioni criminali di stampo mafioso e camorristico.
Per sottrarre ragazzi al loro destino di criminalità bisogna investire molte energie in una educazione al lavoro, da destinare, particolarmente, a quei giovani provenienti da contesti economicamente più svantaggiati e condizionati dal guadagno facile svincolato dall’impegno e dal sacrificio. La parte più complicata consiste proprio nell’insegnare a riconoscere il valore della relazione lavoro-impegno-onestà-legalità e che la dignità del lavoro si esprime non tanto in quel che si fa, ma nel modo in cui lo si fa. Valori che, d’altra parte, dovrebbero ricevere dalla scuola, dalla società ma soprattutto dalla famiglia, perché il lavoro ha una dimensione fortemente identitaria. Se si proviene, infatti, da una famiglia in cui non c’è educazione al lavoro e dove è grande la povertà culturale ed economica, probabilmente si impara che un reddito, indipendentemente dal modo con cui viene procurato, può essere considerato un “lavoro”.
Così, allora, anche fare la sentinella della camorra può essere considerato una occupazione possibile. Difficilmente comprendono che il lavoro onesto costituisce una potente opportunità di liberazione e di emancipazione, altrimenti credo che nessuno di loro si condannerebbe a diventare un servo della gleba del sistema, uno schiavo di camorra in cambio di un po’ di cash e di una manciata di oggetti di status symbol criminale.
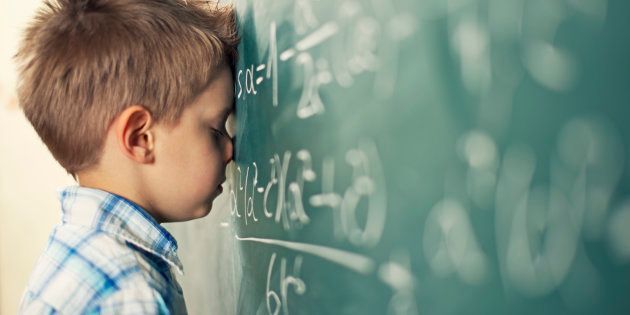
Le rapide considerazioni sin qui condotte fanno capire che l’unico approccio che possa funzionare è quello sistemico-preventivo che lavori su ragazzi, sempre più giovani, ma anche sulle loro famiglie scommettendo sulla responsabilità educativa legata a modelli di riferimento adeguati. Bisogna investire non solo sui genitori, che sono evidentemente inadeguati, ma su tutti gli Adulti significativi, che vivono nell’orbita del minore, rendendoli sempre più consapevoli e responsabili nella capacità di comprendere precocemente atteggiamenti disfunzionali, spesso predittori di comportamenti devianti.
Quando un minore delinque c’è chiaramente una responsabilità del minore, ma è soprattutto un fallimento della relazione formativa con gli adulti che, intorno al minore, avrebbero dovuto e potuto fargli da argine impedendogli di sbagliare. Appare sempre più ineludibile, quindi, strutturare percorsi di accompagnamento formativo e didattico non solo rivolti agli adolescenti a scuola ma a tutti gli adulti che insistono nei diversi contesti di vita (scuola, extrascuola, sport, tempo libero, tecnologie). Abbiamo assistito a politiche educative degli ultimi venti anni tese alla prevenzione e all’intervento su dispersione scolastica e povertà educative che non hanno dato di fatto i risultati sperati.
La politica dovrebbe avere la responsabilità di affrontare i problemi emergenti innescando nel cambiamento, nel senso della maturazione dei cittadini e del loro pieno coinvolgimento, ma essa ha bisogno soprattutto del contributo multidisciplinare di esperti del settore. Per poter costruire politiche e misure efficaci ed efficienti è necessario adottare un approccio multidimensionale che permetta di far emergere i molteplici fattori che influenzano le deprivazioni vissute dai minorenni nella loro vita quotidiana e durante tutto l’arco della loro vita. Servono quindi strumenti che possano misurare la povertà minorile come fenomeno specifico, analizzando “cosa manca”, “dove manca” e “chi sono” i minorenni che vivono situazioni di privazione e di povertà educativa. Ma non basta.
Serve costruire una governance multilivello e intersettoriale; e lavorare in un quadro integrato di politiche, nazionali e internazionali, che si innestano su un sistema di welfare articolato. È necessario, quindi, promuovere una cultura partecipativa sul territorio valorizzando e facendo crescere una sussidiarietà di tipo partecipativo, superando la sussidiarietà basata sull’erogazione di prestazioni, portando alla nascita di progettualità che promuovano le reti relazionali. Bisogna “superare la logica individualistica nell’affrontare la lotta alla povertà, considerando sempre la famiglia come risorsa e realtà da sostenere, perché perno di una politica di sviluppo di welfare comunitario.
Share
Tutti gli articoli












